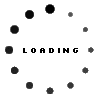di Caterina Franciosi
I RACCONTI DI MALIA
 La brezza del porto di Alesia spettinava la sua chioma color del fuoco.
La brezza del porto di Alesia spettinava la sua chioma color del fuoco.
Luce si passò la mano fra i capelli e si accorse che stavano diventando di nuovo troppo lunghi. Sbuffò. Avrebbe dovuto tagliarli ancora, fosse solo per far dispetto a sua sorella Erinne. La volta precedente si era limitata a bagnarli, a raccoglierli in una coda bassa e a tranciarli di netto alla base con un paio di forbici. Era rimasta piuttosto soddisfatta del risultato, ma Erinne non era stata dello stesso avviso. Era quasi svenuta quando era rientrata a casa e aveva visto la sua nuova pettinatura. Luce si lasciò scappare una risatina ricordando come sua sorella aveva continuato a prenderla a male parole per tutto il tempo in cui l’aveva costretta a stare seduta al tavolo della cucina mentre cercava di rimettere a posto quel disastro.
Quante storie per un taglio di capelli. Come se poi non le fossero ricresciuti. D’altronde, non poteva aspettarsi altro da sua sorella, sempre così bella e profumata.
Luce scivolò tra la gente senza farsi notare, osservando il dondolio delle barche ormeggiate alle banchine, pronte a ripartire l’indomani mattina sfruttando i primi soli primaverili. I mercanti e i pescatori avevano ripreso la loro piena attività dopo i lunghi mesi invernali, in cui la fredda morsa del gelo pareva congelare ogni cosa.
Ma per Luce quella non era stata una bella giornata. Affatto. Era uscita alla ricerca di un lavoro, ma anche quel pomeriggio si era limitata a collezionare l’ennesimo insuccesso. Da quando Erinne le aveva proposto di prendere in considerazione l’idea di collaborare con la famiglia Tagliaferro e Luce aveva replicato con parole irripetibili, sua sorella aveva perso le staffe e le aveva dato un ultimatum.
“Badiamo a te fin da troppo tempo,” aveva sentenziato settimane prima. “Essere una damigella dei Tagliaferro non è quello che pensi tu, ma cercare di spiegartelo è solo fiato sprecato. Perciò ora arrangiati e trovati un lavoro per conto tuo.”
“E la mamma lo sa che mi stai dicendo questo?” aveva ribattuto Luce senza fare una piega.
Erinne l’aveva solo guardata.
“È meglio che ti trovi un lavoro onesto. E che abbandoni il giro della gentaglia che frequenti, non credere che non sappiamo quello che fai.”
E così era cominciata la sua avventura alla ricerca di un’occupazione qualsiasi giù al mercato di Alesia, ma a quanto pareva nessuno voleva saperne di lei. Chi non poteva permettersi di pagarla, chi non ne aveva la benché minima intenzione, chi l’avrebbe invece coperta di monete sonanti in cambio di servizi se possibile ancora più disgustosi di quelli dei Tagliaferro.
Il mercante grasso e sudato con cui aveva discusso poche ore prima le aveva praticamente riso in faccia.
“Ma dove credi di andare con quelle gambette rinsecchite?” le aveva detto sprezzante davanti a tutti. “Ragazzina, io scarico casse di pesce e barili di birra tutto il santo giorno. Cosa me ne faccio di un esserino come te?”
Luce si era trattenuta dal saltargli alla gola e se ne era andata tra gli sghignazzi degli uomini.
“Ciccione,” aveva bofonchiato una volta fuori dalla loro portata. “Ti ci vedo proprio a faticare tutto il giorno, come no.”
Eppure quelle parole avevano continuato a ronzarle nelle orecchie. Quel grassone era stato un villano, certo, ma le aveva rivolto la domanda chiave.
Che cosa sapeva fare lei?
Si allontanò tra le viuzze della periferia a testa bassa, avvolta dal chiacchiericcio dei passanti, riflettendo. Non era brava in alcun tipo di arte, questo era certo. Nel corso degli anni, Erinne aveva tentato – invano – di insegnarle a suonare qualche strumento musicale o qualche canzone, oppure ancora a muovere qualche passo di danza. Nemmeno di ricamare se ne parlava. Luce trattenne una risata, cominciava a capire la disperazione della sorella.
Eppure qualcosa doveva esserci, per gli Dèi. A parte quello, ecco.
Sfruttando le prime ombre della sera, Luce imboccò uno stretto vicolo laterale e si arrampicò su per la parete della casa disabitata alla sua destra, sfruttando inferriate e cornicioni. In un attimo, si ritrovò sul tetto, accucciandosi per ammirare dall’alto lo splendore della città. Il Palazzo di Re Tiberio IV Alesiade si stagliava imponente contro l’orizzonte. Se solo avesse potuto, Luce lo avrebbe distrutto fino all’ultima pietra, fosse stato solamente per annientare suo padre e tutta quella cricca di nobili. Padre… se così poteva definire l’uomo con cui sua madre l’aveva involontariamente concepita. Non voleva nemmeno pronunciare il suo nome. Gli sarebbe bastato alzare un dito per aiutarle, invece si era limitato a prendere ciò che più che gli aggradava in quel momento per poi metterle da parte una volta che ne aveva avuto abbastanza. Come tutti quei ricconi spocchiosi e arroganti suoi amici, del resto. Non era giusto.
Come non era giusto che quei mercanti ciccioni le ridessero in faccia. Se solo avesse avuto qualcosa… Un arco, una balestra…
La gente non faceva caso a lei. Se Luce decideva di non farsi notare era in grado di mimetizzarsi ovunque, come un’ombra tra le ombre. Era in grado di spaventare persino Erinne. Se solo avesse avuto un’arma tra le mani, tutti quei buffoni avrebbero riso molto meno.
Ma erano solo sogni. Uccidere non era sempre così facile – e nemmeno troppo conveniente. Se i Ronconieri l’avessero catturata, sarebbe finita sulla forca in un battito di ciglia.
Luce scivolò verso il bordo del tetto e si incantò dinanzi agli ultimi raggi di sole che incendiavano le nubi più basse a Ovest. Il profumo di carne speziata della locanda poco distante le fece brontolare lo stomaco. Chissà cosa aveva preparato Erinne per cena. Quella sera non lavorava, la mamma non c’era e –
Luce inorridì.
Quella sera la mamma non c’era, Erinne non lavorava e aveva invitato amici per cena. E si era raccomandata di non fare tardi.
Scese dal tetto e corse verso casa. Sua sorella l’avrebbe ammazzata. Ecco un’altra cosa in cui non era brava: tenere a mente gli impegni mondani.
Erinne era furiosa.
“Dove sei stata?” le sibilò non appena le aprì la porta di casa.
“Fuori,” rispose Luce, sgusciando sotto il suo braccio teso. “A cercare lavoro, come mi hai detto tu.”
Erinne fece per tirarle un ceffone e la strattonò dentro.
“Più tardi facciamo i conti, io e te,” le soffiò all’orecchio mentre la conduceva in sala da pranzo.
Attorno al tavolo erano già seduti tre uomini che a Luce fecero subito una pessima impressione.
“Oh, ecco finalmente l’altra splendida signorina Selenides.”
Rinaldo Tagliaferro si alzò e le andò incontro, prendendole una mano tra le proprie per baciarla. Luce trattenne a stento l’impulso di ritrarla, ma la sua espressione doveva essere palese, tanto che Rinaldo sogghignò e le strizzò l’unico occhio che aveva.
“Grazie per essere venuta,” le disse, scostandole la sedia. “Stavamo giusto discutendo di noiosissimi affari. Posso presentarti i miei amici, Giuliano Terrabuona e Santo Dal Rio?”
I due energumeni seduti dall’altra parte del tavolo si alzarono, fecero un breve inchino a Luce e non ripresero posto fino a quando non lo fece anche lei. Erinne le riempì il piatto di stufato senza parlare e Luce colse l’occasione al volo per evitare di rispondere e limitarsi ad un vago cenno del capo.
“Allora, dove sei stata tutto il giorno?” Rinaldo si accomodò e le rivolse un sorrisetto. “Stai facendo ammattire tua sorella, lo sai?”
Luce scrollò le spalle, fissando il fondo del piatto.
“Non è colpa mia se là fuori sono un branco di incivili,” fu la secca risposta.
Rinaldo scoppiò a ridere e riprese a mangiare.
Luce rimase a sedere fra loro, sentendosi più fuori posto che mai, desiderando di trovarsi altrove. Le loro chiacchiere sugli ultimi avvenimenti della città, su chi avesse cercato di infilzare o far arrestare chi, la lasciavano completamente indifferente e la annoiavano a morte. Ascoltava solo a metà i loro discorsi, che per lei avevano lo stesso valore della spazzatura. Ogni parola che usciva dalla bocca dei Tagliaferro per lei era immondizia, ma questo era meglio non dirlo. Ma come accidenti faceva Erinne a lavorare per loro?
“Questo stufato è semplicemente delizioso!” commentò Rinaldo pulendo il fondo del piatto con una fetta di pane. “Non è vero, ragazzi?”
I due scagnozzi annuirono. Luce scoccò loro un’occhiata di sottecchi mentre portava via i piatti sporchi e li riponeva nell’acquaio. Non avevano l’aria particolarmente intelligente, ma erano grossi abbastanza da far passare a chiunque la voglia di infastidire Rinaldo. Con due così alle spalle, anche da lontano sarebbe stato difficile colpire il giovane rampollo dei lenoni di Alesia.
“Luce, vuoi un po’ di frutta?”
Erinne le porgeva il vassoio dalla soglia della porta.
“No, grazie,” rispose da sopra la spalla. “Sto bene così. Finisco di lavare questa roba.”
Erinne scrollò le spalle e tornò in sala. Le risate degli ospiti erano allegre e sembravano anche sincere, ma forse era solo grazie alla bottiglia di vino ormai vuota sulla tavola. Nonostante ciò, l’atmosfera per Luce era soffocante. Di nuovo, desiderò essere altrove, lontana dal quel mondo sporco e contorto in cui – suo malgrado – era nata. Le mancava l’aria alla gola e avrebbe dato qualsiasi cosa per tornarsene di nuovo tra le vie della città, dove nessuno sapeva di lei. Dove nessuno voleva qualcosa da lei.
Mai come in quel momento desiderò essere libera. Libera di tornare a casa all’ora che preferiva – o di non tornarci affatto. Libera di essere chiunque volesse, di nascondersi o meno agli occhi degli altri, di parlare solo con chi fosse di suo gradimento. Libera di non rendere conto ad anima viva delle proprie azioni, se non a sé stessa.
“Scendo a prendere una boccata d’aria.”
Luce abbandonò i piatti nell’acquaio e corse giù, fuori, in strada, dove c’era aria. Respirò a fondo i profumi della sera, già carichi delle prime promesse estive. Si appoggiò al muro del palazzo e rilassò la testa contro la pietra, ma la quiete non durò a lungo. Con gli occhi chiusi, sentì il portone aprirsi accanto a lei con un cigolio dei cardini.
“Erinne, lo so che sei fuori di te, ma dammi un momento.” si lamentò Luce senza muoversi.
Una risata mascolina le fece spalancare gli occhi all’istante. Rinaldo Tagliaferro le stava davanti a braccia conserte, un sorriso sbilenco sul volto sfregiato.
“Oh, sei tu. Scusami.”
“Sei scappata?” Rinaldo si appoggiò al muro vicino a lei. “Le nostre chiacchiere ti hanno provata così tanto?”
“No, io – ”
“Sai,” la interruppe Rinaldo dandole una pacca sul braccio. “È davvero un peccato che ci odi così tanto. Una come te sarebbe… speciale. Non solo per il nome che porti, ma perché c’è qualcosa in te. Qualcosa che accomuna te ed Erinne a vostra madre, mio padre me l’ha sempre detto.”
Luce si staccò dal muro e lo fronteggiò.
“Scordatelo,” disse a voce bassissima. “Non farò mai parte delle puttane dei Tagliaferro. Piuttosto la morte. La mia o quella di tuo padre, se mai si azzardasse a toccarmi con quelle luride mani.”
“Suvvia, suvvia,” rispose Rinaldo con un blando cenno della mano. “Non volevo farti arrabbiare.”
Cominciò ad accarezzarsi il mento con la punta delle dita e rimase a scrutarla a lungo con uno strano scintillio negli occhi.
“E adesso cosa c’è?” sbottò Luce.
“Oh, nulla,” rispose Rinaldo senza cambiare espressione. “Stavo solo pensando che ti credo, sai?”
“Credi a che cosa?”
“A quello che hai appena detto.”
Luce incrociò le braccia sul petto.
“E conosco un lavoro che potrebbe fare al caso tuo,” continuò il giovane davanti a lei.
“Ma non mi dire.”
“Potrà sembrarti strano, ma non abbiamo a che fare solo con allegre damigelle.” Anche Rinaldo si allontanò dalla parete e prese a girarle intorno in un modo che a Luce ricordò uno squalo con la propria preda. “Forniamo diversi servizi, se così possiamo chiamarli. Servizi ai quali non sei del tutto estranea.”
“Senti, spiegati o me ne torno di sopra,” gli disse Luce portandosi fuori dalla sua orbita e cominciando ad innervosirsi seriamente.
“Saresti una perfetta sicaria, Luce Selenides.”
Luce si immobilizzò e sentì la mascella scivolare verso il basso.
“Io – cosa?”
“È un lavoro duro. Rischioso. Ma paga bene, se sei brava.”
“Stai scherzando. Io non vado in giro ad ammazzare la gente.”
“No?” Rinaldo portò il naso all’altezza dei suoi occhi. “Ne sei davvero sicura?”
Luce deglutì. Rinaldo sapeva. Sapeva che aveva già ucciso una volta: Flavio, quell’uomo disgustoso. Ed era perfettamente consapevole del fatto che non fosse nemmeno lontanamente pentita.
Anche quel giorno avrebbe voluto fargliela vedere a quel ciccione borioso, e come a lui, anche a tanti altri, tutte le volte che non avevano esitato a farsi beffe della sua famiglia. O che avevano cercato di approfittarsi di lei solo perché era una ragazza.
“Lo immaginavo.”
Rinaldo si tirò indietro, senza staccare gli occhi dai suoi. Luce era disorientata. Non sapeva cosa rispondere, voleva fuggire e allo stesso tempo la proposta di quel farabutto aveva mosso qualcosa dentro di lei.
“Non mi starai dicendo che c’è un precettore che ti insegna ad ammazzare la gente,” disse, cercando di ritrovare un contegno.
Rinaldo scosse il capo.
“Non si diventa assassini. Lo si è e basta. E tu lo sei, ce l’hai nel sangue, Luce Selenides.”
“Io – ”
“Non negarlo, perché l’ho visto nel tuo sguardo fin dal primo momento. Ti ho osservata, insieme a tua sorella. Ti ho fatta seguire da certi miei collaboratori, per essere certo di non sbagliare. E io sbaglio raramente.”
Il volto di Rinaldo aveva perso ogni traccia di ilarità.
“Non voglio lavorare per voi,” ribatté Luce, testarda.
“Non lavorerai per noi, non se non lo vorrai perlomeno,” rispose Rinaldo, alzando gli occhi al cielo. “Sarai libera di scegliere cosa fare della tua vita. Io ti sto solo dando un’opportunità per non sprecare il tuo talento.”
Luce lo guardò a lungo, meditando sulle sue parole.
“Non credere che sarà facile.” Rinaldo si strinse nella cappa scura e si diresse verso il portone, passandole accanto. “Dovrai studiare, imparare ad usare le armi, scoprire quale sarà la più congeniale per te. Non basta ciò che hai imparato dai tuoi amici del quartiere.”
“Chi?”
La domanda di Luce rimase sospesa fra di loro come una nuvola oscura. Rinaldo si fermò e voltò solo il viso verso di lei, il sorriso mellifluo che si allargava di nuovo sulle sue labbra.
“Conosco gente che farebbe al caso tuo. Ti darei i nomi e da lì la scelta sarebbe solo tua. Potresti decidere che non fa per te, che preferisci trovarti un marito e crescere dei figli, oppure scegliere di dedicarti anima e corpo a questa vita. Insomma, sono affari tuoi. Ma il mio consiglio è quello di darti almeno un’opportunità.”
Luce aprì la bocca per ribattere, ma Rinaldo alzò una mano e la interruppe.
“Non serve che mi rispondi adesso. Prenditi il tuo tempo per pensarci. Lascerò i nomi a Erinne, se mai fossi interessata.”
Rinaldo si allungò verso di lei e le diede un buffetto sulla guancia, scomparendo oltre il portone un attimo dopo.
Senza fiato, spossata come dopo una lunga corsa, Luce rimase lì a guardare la bocca scura del palazzo, ad ascoltare il proprio respiro affannoso nell’immobilità della notte. Sopra di lei, una grande luna piena, unica testimone dei segreti che si annidavano negli anfratti più oscuri del suo cuore.
POSTFAZIONE DI MARCO RUBBOLI
La cara amica Caterina Franciosi ci regala con questo racconto uno squarcio sulla prima giovinezza dell’assassina Luce Selenides di Alesia, una dei personaggi più amati nella saga. Luce non ha avuto una vita facile e al tempo di questo racconto, all’età di quattordici anni, ha già ucciso almeno un uomo (come lei stessa ci racconta nel romanzo). Tuttavia, ancora non ha scelto di fare della morte la sua professione.
Il racconto di Caterina si svolge proprio nel momento di questo bivio cruciale nella vita di Luce. L’invito a cena che sua sorella maggiore Erinne rivolge al coetaneo Rinaldo Tagliaferro (un altro dei nostri protagonisti), segnerà il destino di Luce. Se Erinne avesse saputo prima l’esito di quell’invito, di certo non lo avrebbe mai fatto.
Veniamo poi a sapere che Luce, oltre ad apprendere varie arti di combattimento dai suoi amici cattivi del quartiere, avrà un precettore di tiro consigliatole da Rinaldo stesso: una figura misteriosa molto importante per lei, ma che per ora rimane nell’ombra.
Ancora un grazie di cuore a Caterina per la sua partecipazione al progetto di questa saga. Conto di poter sfoggiare in futuro anche altri piccoli o grandi contributi provenienti dalla penna di amici scrittori… e magari anche qualcosa d’altro di Caterina, se a lei piacesse. Elelai!
LINK
Blog: https://salottoletterario20.blogspot.com/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ilsalottoletterario
Instagram: caterinafranciosi

Luce Selenides
Regno di Malia